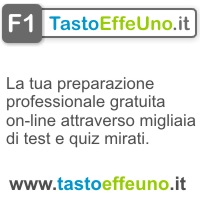|
022 ..:: 28.06.2015 - 20:00

..:: Il professor Gabriele Di Francesco, dell'Università "G.
D'Annunzio" di Chieti-Pescara durante il suo intervento
sulla "Comunicazione e comunità partecipata".
RUVO DI PUGLIA ..:: Gli
argomenti trattati dai relatori durante il IV Convegno
Nazionale delle Pro Loco, svoltosi a Ruvo di Puglia (BA) il
20 e il 21 giugno, sono stati tutti di grande rilievo. Molto
interessante è stato quello introdotto da Gabriele Di
Francesco, docente presso l’Università degli Studi «G.
D’Annunzio» di Chieti e Pescara dal titolo “Comunicazione
e comunità partecipata”.
Il professor Di Francesco, dopo aver precisato che “La
comunicazione nella sua prima definizione è l’insieme dei
fenomeni che comportano la distribuzione di informazioni”,
ha evidenziato il “concetto di comunità” che è un insieme di
individui, che condividono lo stesso ambiente fisico e
tecnologico, formando un gruppo riconoscibile, unito da
vincoli organizzativi, linguistici, religiosi, economici e
da interessi comuni. Quindi la comunità è un «gruppo
sociale».
Un excursus tra gli uomini del passato che hanno affrontato
sia la “comunicazione” in quanto tale, sia “la comunità
partecipata”. Tra questi, il Di Francesco segnala numerosi
autori.
Ferdinand Tonnies (1855-1936) la comunità è vita
reale e organica, è convivenza confidenziale, intima,
esclusiva, si nasce e si è legati da subito con gli altri
membri, nel bene e nel male.
Emile Durkheim (1858-1917) mette in risalto che nella
società tradizionale prevale la solidarietà meccanica, una
struttura valoriale, in cui l’individuo si trova inserito
sin dalla nascita. Inoltre, il «gruppo di scopo» sono gruppi
eterogenei che si dividono i compiti per il raggiungimento
di uno scopo comune. In questo caso l’individuo vi partecipa
volontariamente.
Un altro autore del passato che viene portato alla ribalta,
in modo brillante dal professor Di Francesco è senza alcun
dubbio Max Weber (1864-1920) che propone due
idealtipi di relazione sociale nei quali l’agire sociale
poggia su basi differenti: la comunità e l’associazione. Una
relazione sociale è da definirsi comunità quando la
disposizione dell’agire sociale poggia su una comune
appartenenza soggettivamente sentita degli individui che ad
essa partecipano. Deve essere definita associazione quando
la disposizione dell’agire sociale poggia su una identità di
interessi, oppure su un legame razionale diretta verso
interessi di valore, ovvero sulla credenza della sua
obbligatorietà, o di scopo, cioè sull’aspettativa di lealtà
tra le parti. Il docente universitario si sofferma altresì
su Georg Simmel (1858-1918) che afferma che «il
gruppo non rappresenta il soffocamento dell’individuo ma, al
contrario, il milieu socio-culturale e relazionale in cui
esso sviluppa al meglio le sue potenzialità». Il gruppo
appare quindi come l’esito di complessi processi relazionali
che si fondano essenzialmente sulla collaborazione di più
individui per il conseguimento di una mèta comune.
L’appartenenza a più gruppi garantisce all’individuo una o
più spiccata identità sociale e quindi una maggiore
valorizzazione della propria personalità.
Il Di Francesco approfondisce il pensiero di William
Summer (1840-1910) ossia, che gli appartenenti ad una
comunità, ad un gruppo, sviluppano una particolare
solidarietà tra loro, un “senso del noi” che governa la
coesione di un gruppo.
Per Summer l’in-group è fonte di etnocentrismo, fondamento
del conflitto tra gruppi e carattere naturale del meccanismo
di selezione dei gruppi sociali che porta alla crescita del
gruppo.
Particolare attenzione è stato dedicata a Charles Horton
Cooley (1864-1929), il primo ad occuparsi di “gruppi
sociali”. Si deve a Cooley la definizione del concetto di
“gruppo primario”, gruppo “faccia-a-faccia” attraverso il
quale ognuno può esprimere se stesso attraverso la
“solidarietà” e la “cooperazione”.
Tra i community studies più noti devono essere annoverati
quelli condotti da William Thomas e Florian
Znaniecki confluiti nel libro “The Polish peasant in
Europe and America (1918-1920).
Non mancano le considerazioni sull’operato di Robert K.
Merton (1910-2003) che individua gli aspetti in cui
l’individuo non è socializzato e non aderisce ai mezzi ed ai
fini della società, non accettando, pertanto, ogni status e
ruolo socialmente prestabilito e funzionale al mantenimento
del sistema sociale. Da ciò il termine “devianza”. E’ bene
chiarire i concetti riferiti al “gruppo di riferimento” e al
gruppo di appartenenza”. Il gruppo di riferimento con un
sentimento di “privazione relativa” non è necessariamente il
gruppo di appartenenza, ma un gruppo a cui l’individuo tende
a riferire la propria condotta anche senza esserne membro.
Il problema è se il soggetto ha i requisiti per far parte
dello stesso gruppo. Se li ha può accedere al nuovo gruppo e
realizzare un processo di mobilità orizzontale e verticale,
in caso contrario corre il rischio di restare fuori al
sistema di appartenenza precipitando in una situazione di
marginalità e anomia.
Il prof. Di Francesco con le sue slide di conclusione del
discorso evidenzia che «La comunità è dunque un gruppo
sociale. Un gruppo sociale è il flusso di comunicazione che
passa tra i suoi componenti. Il gruppo è il flusso di
comunicazione che passa al suo interno. Le reti e le
strutture della comunicazione nel gruppo. Il conflitto come
rottura della comunicazione nel gruppo». Insomma, continua
il docente universitario, «La comunicazione è il modo di
relazionarsi, di fare gruppo, di cercare e trovare identità
individuale e identità sociale per costruire i propri ambiti
valoriali, i propri spazi socio-vitali attraverso azioni
dotate di senso».
Il professor Gabriele Di Francesco, continua l’accattivante
discorso con «L’innovazione tecnologica e le web community»
soffermandosi sulla società post-moderna. Il postmoderno è
costituito da una nuova ricerca di legame sociale di tipo
comunitario come risposta ad un tessuto più debole e
fragile, in cui le persone si sentono più sole e meno
protette dalla comunità. Il post-moderno corregge o rinnega
il mito di fiducia illimitata nel progresso e nella
modernità quali portatori di sviluppo, benessere e libertà.
L’idea stessa di libertà, strettamente legata a quella del
progresso, si è trasformata in inquietudine e sradicamento
per le persone che vivono nel mondo globalizzato.
Non mancano citazioni di Michel Maffesoli nel “Il
tempo delle tribù” del 1988, che ricorre metaforicamente
alla nozione premoderna di tribù nel tentativo di “trovare
le parole meno false possibili per dire ciò che è”.
Laddove mancano concetti già formati per descrivere la
socialità postmoderna, infatti, è necessario accontentarsi
delle metafore, delle analogie, delle immagini, che
costituiscono il mezzo inadeguato possibile per dire “ciò
che è” e “ciò che sta nascendo”.
Sottolinea altresì che l’autore Bernard Cova amplia
il termine di «neo-tribù» e spiega la postmodernità come
“sinergia dell’arcaismo e dello sviluppo tecnologico”. Per
le neo-tribù, la tecnologia diventa il fattore determinante
per la loro esistenza stessa, a differenza delle tribù
arcaiche. Il web 2.0 amplifica la possibilità di stabilire
delle connessioni e creare comunità in grado di scambiarsi
esperienze e saperi senza costrizioni di spazio e tempo.
Abbiamo così frasi come: umanizzare il messaggio, fare
cultura, fare rete culturale, riflessione e lentezza, poca
invasività, spazi socio-vitali, gruppi aperti, concezione
affettiva/organica e non razionale, ecc…
Un altro argomento affrontato dal docente universitario è
quello relativo al «Multiperspectival journalism». Un
giornalismo nuovo con lo sviluppo della tecnologia per
tutti.
Negli anni novanta del Novecento ritorna in auge il concetto
di comunità inteso non più come dato storico esistente ma
come qualcosa da ricostruire socialmente, quale necessità
storica fatta di identità, reciprocità, fiducia,
cooperazione, solidarietà, responsabilità, norme che
regolano la convivenza, reti di associazionismo civico.
Per quanto riguarda il concetto di cittadinanza attiva il
docente segnala: I piccoli mondi, I mondi della vita
quotidiana, Il volontariato e il senso civico, L’impegno
solidale e di network.
Il professor Gabriele Di Francesco, afferma che «in una
accezione più ristretta e pregnante, la comunità è ben più
della semplice appartenenza o convivenza. E’ il sentimento e
l’agire di comunità, è ciò che concerne il pubblico, è ciò
che riguarda tutti. La comunità è l’agire che antepone la
struttura valoriale della collettività a quella personale, è
il sentirsi parte di una comunità che diventa fattore
operante di solidarietà. La comunità, appunto,
“partecipata”».
Agostino Del Buono
agostino.delbuono@lasestaprovinciapugliese.it
© Riproduzione Riservata.

..:: Un primo piano del professor Gabriele
Di Francesco, dell'Università "G. D'Annunzio" di
Chieti-Pescara durante il suo intervento sulla
"Comunicazione e comunità partecipata".
|